Luciano Canfora lo ha voluto compartecipe di un grande progetto editoriale, la prima traduzione integrale della Biblioteca di Fozio. Così come il professor Giovanni Reale gli aveva affidato l’incarico dell’edizione completa delle opere del bizantino Pletone, “principe dei filosofi del suo tempo” come reca l’iscrizione sull’arca del Tempio Malatestiano. Chi è? Il riminese Moreno Neri. Che qui presenta il volumone, regola due piccoli conti (con Natalino Valentini e Nando Piccari) aperti e spiega, avendo davanti agli occhi il Partito della Nazione sbocciato alla corte di Gnassi, perché la dottrina platonica assuma oggi particolare attualità proprio a Rimini.
Da qualche giorno, per le prestigiose Edizioni della Normale di Pisa, è finalmente in commercio la Biblioteca di Fozio. Fozio (820-891), per due volte patriarca di Costantinopoli e santo per la Chiesa Ortodossa, è stata una figura dominante nella “seconda Roma”, in un periodo in cui l’impero bizantino era la più grande potenza mediterranea. Per gli studiosi della letteratura greca antica e protobizantina, il nome di quest’uomo di vastissima cultura richiama immediatamente la Biblioteca, un imponente repertorio che è stato definito “l’opera più importante di storia letteraria del medioevo”. È una collezione che in 280 capitoli (o codici) trascrive o in parte riassume, e analizza e commenta, più di un centinaio di autori – pagani e cristiani –, scrittori che per la maggior parte sarebbero per noi altrimenti perduti. In questo volumone (quasi millequattrocento pagine per un peso di più di tre chili!) viene finalmente offerta ai lettori la sua prima traduzione italiana integrale, a fronte della quale, su una delle due colonne per pagina, figura il testo greco della Biblioteca, migliorato rispetto all’unica moderna edizione circolante, quella francese della “Collection Budé”. Al tempo stesso un commento sistematico ed essenziale accompagna il lettore nella selva fittissima della erudizione racchiusa in questo autentico “tesoro”, come i grandi umanisti amarono definire la Biblioteca foziana. Al termine, indice analitico e bibliografia forniscono ai lettori e studiosi preziose chiavi per la consultazione e per l’ulteriore ricerca.
Si sarà compreso come la complessità di una simile opera abbia richiesto una bella impresa collettiva, e insieme coerente, di studiosi provenienti da ogni parte d’Italia. Nel manipolo di trentuno curatori l’unico riminese è il sottoscritto. Luciano Canfora che mi ritiene “dotto” e provvisto “di una ferrea volontà e larga dottrina” mi ha voluto compartecipe di questo progetto editoriale affidandomi la cura del “codice” 247 A Platone, in difesa della retorica. Conoscendo il mio “platonismo militante”, Canfora – che molti riminesi hanno recentemente potuto ascoltare nella sua lectio magistralis sul tema “Chi sono gli antichi” in occasione del XVIII Festival del Mondo Antico – mi ha voluto affidare un testo che affronta in maniera sistematica la critica di Platone della retorica e, soprattutto, da un esponente di tale tecnica come Elio Aristide (117-180) che attacca Platone pur venerandolo. Per altro il Gorgia, il dialogo dove Platone conduce la sua serrata critica alla retorica, l’arte del discorso, centrale nella spregiudicata attività dei politici che mirano unicamente al proprio utile e incapace di migliorare i cittadini insegnando il bene e la virtù, non contiene argomentazioni che riguardano solo l’Atene di Pericle del V sec. a.C. o, nel caso della critica di Elio Aristide, l’Impero romano della dinastia degli Antonini, ma è un problema che riguarda, con amara e obiettiva tristezza, anche la politica del nostro tempo, perché il discorso della politica è durevole e sfida i millenni.
Qualsiasi autentico politico, amante della conoscenza, anche del nostro tempo oscuro, dovrebbe leggere questo dialogo – che seppur antico ci riguarda –, conoscerlo e meditarlo se vuole veramente cercare il bene per sé e per il prossimo. Ma anche per i cittadini-elettori, sempre più espropriati della loro sovranità a favore di una democrazia non più rappresentativa ma “recitativa”, come l’ha ben definita Emilio Gentile nel suo Il capo e la folla, il richiamo salutare alla dottrina platonica capace di mettere sotto accusa in via definitiva il carattere volgarmente seduttivo della parola politica suona oggi particolarmente attuale e ancor più a Rimini dove si sperimenta in laboratorio il Partito Unico della Nazione, che si vuol fare apparire come il migliore fra le migliori forme di amministrazione, mentre, nella realtà, potrebbe essere la peggiore fra le peggiori, la più degenerativa, una raffinata forma di demagogia come fu la democrazia criticata dagli antichi greci. Per quanto la materia di cui mi occupo sembri, in apparenza, poco esposta politicamente, quella antica è in realtà una letteratura assolutamente intrisa di politica. Basta volgere lo sguardo alle questioni sociali, alla necessità di un’etica nella politica e alle tematiche dell’ecologia per rendersi conto che ciò che per convenzione moderna viene ancora chiamata “sinistra” non ha concluso il suo cammino, ma lo sta appena cominciando. E in ciò non c’è un residuato della politica o intelligencija “d’antan”, cioè ante annum – “l’anno passato” e per estensione “un tempo” – bensì qualcosa che interessa molto da vicino il futuro delle persone e di tutta l’umanità e che non potrà che essere che uno spazio composito ed eterogeneo, solidale e rispettoso, curioso e dialogante.
Se si pensa a quella che è stata in questi anni la mutazione antropologica del Pci, ben si comprende il fastidio, come antichità di parrucconi, verso ogni istanza e concreta testimonianza di maggiore eguaglianza, di maggiore giustizia sociale, e infine di maggior decenza e dignità da parte di chi gode il privilegio del potere o ha le mani in pasta con i poteri finanziari, la cui trasparenza e serietà è, da alcuni anni, sotto gli occhi di tutti i riminesi (al punto che si finisce per dar ragione a Bertolt Brecht quando si chiedeva poeticamente nell’Opera da tre soldi: “Che cos’è l’effrazione di una banca di fronte alla fondazione di una banca?”) e con ogni oligarchia del trafficare e del costruire.
Aldilà di queste considerazioni che per quanto amare non mi rendono malmostoso, avendo nel corso di questi anni trovato dentro di me sufficiente pace e pochissime rivalse dell’ego o della mente non saggiamente diretta, la richiesta di traduzione, emendamento del testo e commento da parte di Luciano Canfora mi ha reso particolarmente soddisfatto. Come ha detto recentemente un caro amico e compagno ritrovato come Alessandro Cavuoti, che in questi anni ha avuto un percorso spirituale diverso del mio ma analogo (perché i rami sono diversi ma tutti riconducono allo stesso tronco): “Dell’acredine ce ne infischiamo. A noi piacciono le fragole”. Ci piacciono anche i fiori di campo per la loro gratuità.
Cosa ho fatto ultimamente che mi ha reso buon cittadino? Alla disgregazione del tessuto democratico si possono contrapporre una recuperata consapevolezza e una “controdemocrazia” critica ma positiva individuando sguardi, azioni e metodologie alternative e non convenzionali.
Intanto, nel mio stretto ambito, la mia scelta socratica di non ricevere pressoché compenso alcuno mi assicura una totale libertà e “fecondo nell’animo, lascio traccia di me nelle opere dell’ingegno”. Ho il timore che questa mia singolarità che non è “aristocratica ‘vipperia’”, in un contesto come quello riminese fortemente segnato da voglia di accaparramento e nel quale un po’ tutti si sentono obbligati a lucrare qualcosa da quello che fanno, che scrivono e che dicono, susciti un’assodata fastidiosità e disappunto. Eppure questo modo di vivere offre – lo assicuro – inaspettati compensi e un impensabile ricco patrimonio di crediti e maestose soddisfazioni ad altri inaccessibili.
Eccone uno di questi appagamenti. Sono passati ormai quindici anni da quando, col pretesto di criticare un convegno sul Tempio malatestiano (dei cui esiti si avrà occasione di parlare un’altra volta), fui definito sul numero del 28 ottobre 2001 del settimanale Il Ponte “il curatore di discutibili traduzioni del filosofo bizantino Giorgio Gemisto Pletone”.
Avrei potuto, a quel tempo, al severo e arcigno censore replicare che forse non aveva neppure letto quella mia prima traduzione del De Differentiis di Gemisto Pletone, dato che nella prefazione ammettevo candidamente che forse la mia era la migliore sulla piazza mondiale, poiché mi ero anche potuto avvalere di una precedente traduzione in inglese e di una in francese.
Ma già, lungo il mio faticoso percorso autorealizzativo, avevo appreso che non si deve indulgere a qualsiasi polemica, ma che ci si deve limitare a esporre la propria “dottrina così come è a coloro che possono comprenderla, denunciando in pari tempo l’errore dovunque esso si trovi, facendolo risultare tale col proiettare su di esso la luce della conoscenza vera”.
L’impudicizia di quell’acrobatico e spericolato giudizio doveva essere svelata e messa alla luce quando le mie prime “discutibili traduzioni” caddero, non per mia volontà, tra le mani del compianto Giovanni Reale (1931-2014). Quello che è stato il più grande interprete italiano di Platone mi contattò, lo incontrai il 2 aprile 2006 nell’allora sede della RCS. Ricordo ancora vividamente la stanza, le cui pareti erano ricoperte di scaffali che contenevano tutte le edizioni italiane e le traduzioni straniere de Il nome della rosa, dove si svolse il nostro colloquio alla presenza di Giuseppe Girgenti, il massimo esperto italiano di Porfirio, e Pier Davide Accendere, il massimo conoscitore di Bessarione. In questo consesso di platonici e neoplatonici venne a salutarci il giovane Diego Fusaro, che conoscevo come curatore del sito internet Filosofico.net e ora irresistibilmente asceso ai fasti televisivi per le sue peculiarissime posizioni marxiste e sovraniste. Fu allora che il professor Giovanni Reale mi affidò l’incarico dell’edizione completa delle opere del bizantino Pletone, “principe dei filosofi del suo tempo” come reca l’iscrizione sull’arca del Tempio Malatestiano.
Per le collane filosofiche “Testi a fronte e “Il pensiero occidentale” dirette da Reale ho in questi anni pubblicato, Macrobio / Commento al sogno di Scipione (2007), Giorgio Gemisto Pletone / Trattato delle virtù (2010) e Gotthold Ephraim Lessing – Johann Gottfried Herder / Dialoghi per Massoni (2014). E ora sto ultimando la raccolta degli scritti politici di Pletone sotto il titolo Siamo Elleni, cui seguirà l’edizione dei suoi due trattati antiaristotelici.
Proprio grazie a un mio ricordo sulla presentazione di Rimini di Pier Vittorio Tondelli pubblicato da Rimini 2.0, Mario Andreose, uno dei più importanti protagonisti da decenni della scena editoriale italiana, ha voluto ricordarmi nel supplemento domenicale del 9 agosto 2015 de Il Sole 24 Ore come uno degli artefici di quell’evento. E come mi ha definito? “Moreno Neri, esperto del neoplatonico Pletone e di filosofia massonica, allora presidente dell’Arci”.
Come si diceva: son soddisfazioni! Come ebbe a dire il mio fratello Voltaire: “il tempo è galantuomo e rimette ogni cosa al suo posto”. Nel mio percorso di nicchia il mio posto è alla vetta o in un punto dove, al massimo, solo io posso capire di non essere ancora in cima.
Quanto ai severi e accigliati fustigatori della vita altrui, nemici della propria e precettori universali, attraverso i loro avventati giudizi si sarà compreso che emana odore non solo di bufale, ma pure della stalla in cui le bufale alloggiano.
Nota finale ad uso del lettore non necessariamente informato: il primo critico delle mie traduzioni è Natalino Valentini, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”. Mi dicono esperto di Florenskij, nonché filosofo, teologo e antropologo. Non lo conosco, non l’ho mai conosciuto e sto lo stesso ottimamente.
Il secondo che, se non mi sbaglio, nel suo ultimo sedicente graffiante corsivo mi annovera tra “i malmostosi intellettuali d’antan” che, tra gli altri, compongono l’eterogenea miscela del movimento di Rimini People, è l’amico di vecchia data, e ora avversario politico, Nando Piccari. Persevero, a dispetto dei suoi numerosi scivoloni di questi ultimi mesi, a considerarlo un amico e dovrà farsene una ragione.
Entrambi, Piccari e Valentini, siedono su scranni di diverso ordine della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini la cui mission è quella di contribuire al progresso civile, culturale, sociale ed economico della nostra comunità locale. Povera Rimini, e povere la sua civiltà e la sua cultura.


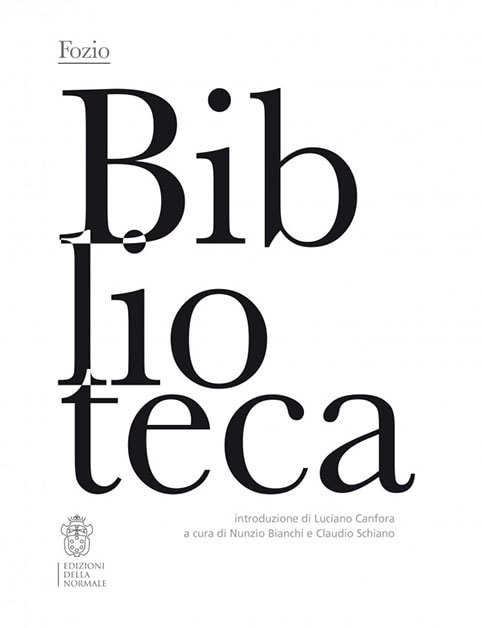
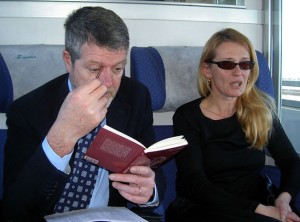
COMMENTI