Quello che Panzini scrive a tappe, dal luglio del 1914 al maggio del 1915, e poi dal 15 al 16 e ancora nel 1918, con una ulteriore coda su Caporetto, resta un originalissimo approccio al tema.
Chissà come avrebbe commentato i tanti “patatrac” dei nostri giorni. E’ infatti con questo suono che Alfredo Panzini annota il 29 agosto 1914: “Stamattina, patatrac!” Qualcosa si è rotto. Definitivamente. Della rovinosa frattura, che in Europa provocherà otto milioni e mezzo di morti e venti milioni di feriti, si celebra quest’anno il centenario, che coincide con una scacchiera mondiale incendiata da conflitti di diversa natura. Libia, Ucraina, Israele, Siria, Iraq. Ma l’elenco completo è lungo.
Fa bene in questi giorni rileggere Il diario sentimentale della guerra di Alfredo Panzini, appena ristampato (con l’aggiunta di inediti interessanti) per le edizioni Pendragon a cura di Marco Antonio Bazzocchi, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di Bologna e responsabile scientifico della Casa Rossa di Bellaria.
Quello che Panzini scrive a tappe, dal luglio del 1914 al maggio del 1915, e poi dal 15 al 16 e ancora nel 1918, con una ulteriore coda su Caporetto, resta un originalissimo approccio al tema. Composto col metodo del diario, cioè, come scrive Bazzocchi, “con le voci dei testimoni anonimi, dei viandanti notturni persi nelle città, dei contadini risentiti per la guerra voluta dai padroni, dei giornalisti che si alambiccano per trovare risposte, degli intellettuali, dei poeti, della gente comune”. Strano modo per raccontare le guerre. Ma Panzini è scrittore che sorprende. Per anni è stato descritto come un intellettuale ammuffito, al pari della piccola borghesia che ha raccontato, che appiccica ideologia sulla carne viva della vita. Invece lo scrittore de La lanterna di Diogene frantuma i sistemi che incasellano il mondo, è innamorato della realtà e da essa si fa trafiggere. Panzini è quella spugna, che già si è vista all’opera nel Dizionario Moderno, che imbeve nella realitas.
Dopo aver parlato un lungo pomeriggio con Renato Serra, Panzini appunta nel Diario questa frase lapidaria: “… ma il discorso moriva, si infrangeva stanco contro la muraglia di bronzo della realtà”. Il rispetto religioso della “realtà sovrana”, scriveva in quegli anni Charles Péguy. Non è forse un caso che in un Diario zeppo di destini e avvenimenti, storia e passioni, Panzini c’infili anche il socialista convertito che cade al fronte il 5 settembre 1914: “E’ morto per la patria un giovane non oscuro, Carlo Peguy, autore di un bel libro sul Mistero di Giovanna d’Arco”.
Mentre si occupa dell’argomento principale, Panzini si sintonizza con molti altri. Peguy, ma soprattutto Clemente Rebora e Renato Serra (e contemporaneamente fa i conti con Benedetto Croce e Giolitti, D’Annunzio). Rebora e Serra in modi diversi presenze imponenti in questo racconto della guerra. Che è “privato” e soggettivo, certo, ma almeno dichiaratamente, senza pretese di oggettività. Mentre gli storici di professione – scrive nella dedica al Diario sentimentale luglio 1914 maggio 1915 – che hanno la pretesa di scrivere “per scienza e per metodo, messi poi insieme, formano una grande confusione e contraddizione”.
Le guerre scoppiano per cause diverse ma hanno tutte una radice quasi comune e medesime conseguenze. “La guerra non paga nessun debito, tutt’al più apre nuove partite”, scrive il 5 maggio 1915.
“La mia preoccupazione non è la guerra. E’ un’altra cosa strana, cioè che non mai come in quest’ora mi apparve trasparente la animalità dell’uomo”.
Panzini sa che la storia non cammina verso un progresso indefinito, ma annaspa verso mete incerte zavorrata dalla bestialità che si annida nel cuore dell’uomo, voragine sempre aperta che può inghiottire popoli interi. “Il baratro dell’umanità non ha fine”. E “le democrazie possono essere bellicose e tiranniche più delle aristocrazie”.
Sui trentuno quaderni che riempie come uno scolaro desideroso di capire, facendosi sorprendere dai fatti, siano essi cartoline e lettere che riceve dal fronte e che incolla come squarci di verità dentro una narrazione “sentimentale”, oppure ritagli di giornale, sparge osservazioni taglienti come la lama di un rasoio.
Il bersaglio principale è la Germania: “Il volto che la Germania discopre è disumano. E’ la distruzione di tutto ciò che non è teutonico”. Che cosa ha dato la Germania al mondo, si domanda. Lutero (“un grosso villano”), Faust (“un idiota che meritava di andare all’inferno e non in paradiso”), “poi molta filologia, molta chimica, molta organizzazione: belle cose, ricalcate da brava gente seria su quello che già noi facemmo”. Poveri tedeschi, infierisce Panzini, “destinati sempre a rimanere, con tutte le loro violenze e le loro previsioni, grossi villani come Lutero. Uccidono chi non capisce la loro civiltà e poi stringono la mano al morto e pretendono che esso ringrazi: Danke sehr!”. Ce n’è abbastanza per mandare in sollucchero milioni di europei che vedono nella Kanzlerin culona la nefasta regia di una Unione Europea che è all’origine dell’eurocrisi e della miseria che sta affondando vari paesi, Italia compresa.
Alfredo Panzini, Diario sentimentale della guerra, a cura di Marco Antonio Bazzocchi
Edizioni Pendragon, collana “Archivio Alfredo Panzini”
Settembre 2014, pagine 349
16 euro


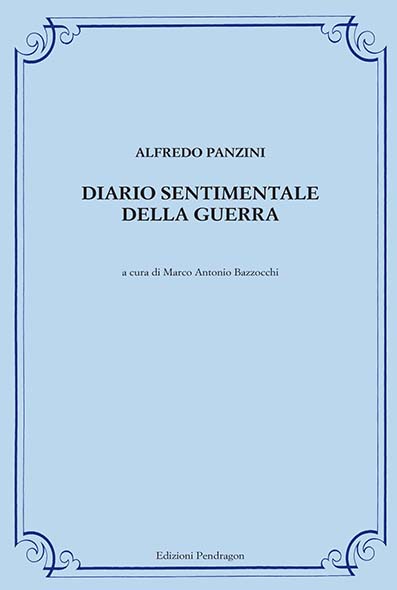
COMMENTI